La progettazione ambientale coinvolge progettisti, produttori e operatori di cantiere, chiamati oggi a confrontarsi con due principi operativi differenti. Il primo interpreta l’architettura come bordo: superficie tecnica che isola e controlla gli scambi con l’esterno.
Il secondo concepisce il progetto come flusso: un sistema aperto che interagisce con cicli termici, idrici, vegetali, metabolici, materici e cognitivi. Il bordo agisce per contenimento e separazione, il flusso attiva connessioni e integrazioni. Cosa comporta questa differenza logica per i diversi attori del processo costruttivo?
Due orientamenti
I progetti raccolti in questo numero mostrano chiaramente questi due orientamenti. Il JST Production Engineering Center ad Harrisburg, di Ryuichi Ashizawa con Arcari + Iovino, sviluppa l’edificio partendo dal suolo. Gli swales distribuiscono l’acqua piovana, le radici vegetali guidano l’umidità in profondità, la vegetazione regola temperatura e umidità atmosferica. Qui il costruito si integra direttamente nei cicli biologici e idrologici, trasformando le superfici architettoniche in infrastrutture climatiche e contribuendo al bilancio del carbonio e alla qualità ambientale.
Il sistema FlectoLine a Friburgo, realizzato da ITKE e ITFT, è basato su un involucro adattivo. I pannelli fibrorinforzati, alimentati da celle fotovoltaiche integrate, reagiscono autonomamente alla pressione atmosferica, regolando luce e temperatura.
Ogni modulo è un’interfaccia dinamica che produce effetti climatici, percettivi e fisiologici, influenzando comfort visivo e biologico degli utenti. L’edificio si configura come organismo energetico attivo.
Massa e adattabilità
Il progetto di BIG in ambito desertico segue invece un approccio basato sulla massa. Le superfici costruite generano ombre, proteggono dal clima e controllano i flussi d’aria tramite inerzia termica e schermature.
L’architettura mantiene una separazione chiara rispetto ai cicli ambientali, interagendo con il clima principalmente attraverso opposizione e barriera fisica.
Il passaggio dal bordo al flusso ha implicazioni dirette per tutti noi. Per noi progettisti vorrebbe dire diventare ecologi capaci di integrare competenze botaniche, fisiologiche e climatologiche nella pratica quotidiana.
Per i produttori di materiali vorrebbe dire sviluppare sistemi materici adattivi, capaci di modificare in tempo reale le proprie proprietà fisiche e chimiche in risposta ai parametri ambientali.
Per gli operatori di cantiere passare dall’assemblaggio statico alla gestione dinamica e dei sistemi climatici e biologici, con il cantiere che evolve da luogo di costruzione a infrastruttura viva e responsiva, nella quale ogni figura professionale contribuisce attivamente alla rigenerazione ambientale.
In cantiere
I cantieri Porta Dipinta a Bergamo, Porta dei Leoni a Roma e la Cittadella dell’Accoglienza, che approfondiamo in questo numero, sono esempi di come una visione avanzata dell’architettura e dell’ingegneria possa garantire ambienti di lavoro più sicuri, processi più efficienti e strutture migliori per la comunità.
Porta Dipinta: il dialogo tra passato e presente
Il cantiere di Porta Dipinta ha dovuto affrontare sfide particolari: il contesto storico e archeologico della città di Bergamo ha richiesto soluzioni che bilanciassero tutela e innovazione.
Fin dal 2005, il progetto ha previsto la realizzazione di un parcheggio interrato, ma la scoperta di importanti reperti ha trasformato l’intervento in un’opportunità unica di valorizzazione del patrimonio.
La collaborazione tra il Comune, la società Seventeen srl e la Soprintendenza ha assicurato un monitoraggio costante, riducendo al minimo l’impatto dei lavori sulla struttura storica.
Il metodo top-down ha permesso di ottimizzare la sicurezza nel cantiere, garantendo stabilità e riducendo i rischi per i lavoratori.
Porta dei Leoni: riqualificazione e sostenibilità
A Roma, il progetto di Porta dei Leoni ha rappresentato un esempio di riqualificazione urbana sostenibile. L’intervento ha mantenuto sagoma e volumetria del vecchio edificio, precedentemente sede della Direzione Provinciale del Tesoro, integrando un linguaggio architettonico più contemporaneo e performante.
La demolizione controllata ha ridotto l’impatto ambientale e garantito misure di sicurezza avanzate per le maestranze. Inoltre, la progettazione ha considerato efficienza energetica, isolamento acustico e riduzione dei consumi, dimostrando che sicurezza e sostenibilità possono e debbono coesistere.
Cittadella dell’Accoglienza: architettura inclusiva
La Cittadella dell’Accoglienza rappresenta un nuovo paradigma nel settore sanitario e assistenziale. La struttura è pensata per garantire benessere agli ospiti, con ambienti accessibili, luminosi e studiati per favorire l’orientamento e la socializzazione.
Il nucleo Alzheimer, il centro diurno e gli spazi per la riabilitazione sono organizzati attorno a corti verdi, contribuendo a un contesto terapeutico e sicuro. La sicurezza si riflette anche nelle soluzioni costruttive: i materiali impiegati sono certificati per garantire salubrità e durata nel tempo, mentre la distribuzione funzionale permette percorsi fluidi e senza barriere.
La sicurezza parte dalla progettazione
L’interazione tra progettisti e coordinatori della sicurezza è determinante per garantire la tutela nei cantieri. Secondo la curva di Mac Leamy, intervenire nelle fasi iniziali della progettazione è più efficace e meno costoso rispetto agli adattamenti successivi.
L’architettura deve integrare la sicurezza attraverso scelte precise, come la selezione di materiali, le tecnologie costruttive e la gestione degli spazi. La triade vitruviana Firmitas, Utilitas et Venustas si traduce oggi in obiettivi di qualità strutturale, estetica, risparmio energetico e sicurezza per lavoratori e utenti finali.
Un cambio di paradigma
Questi tre cantieri dimostrano che il futuro dell’edilizia passa attraverso un approccio integrato alla sicurezza. Dalla gestione dei rischi alla prefabbricazione avanzata, fino alla concezione inclusiva della Cittadella dell’Accoglienza, è evidente che costruire non significa solo realizzare edifici, ma garantire spazi sicuri, efficienti e sostenibili.
Investire in sicurezza significa migliorare la qualità del lavoro, ottimizzare le risorse e costruire un futuro migliore per le città e le persone.
di Livia Randaccio, Emanuele Naboni
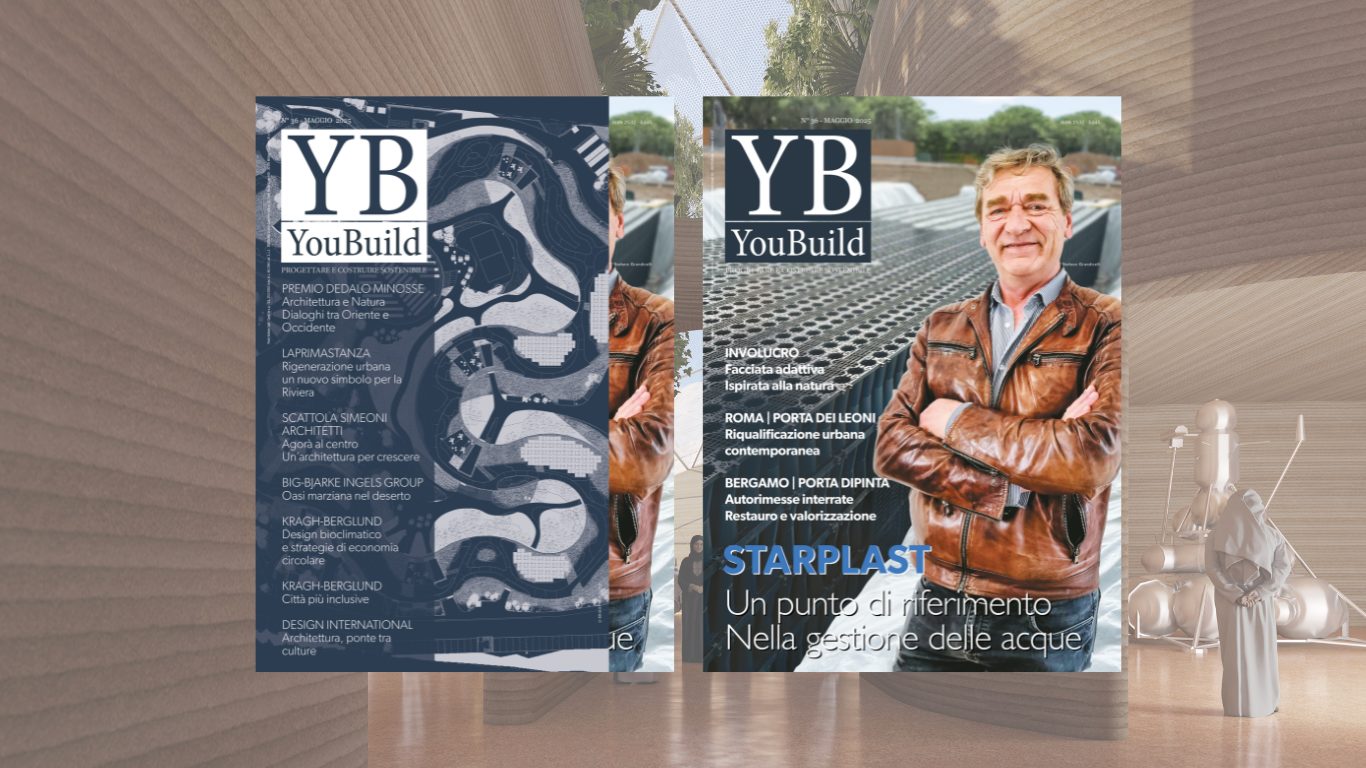
Se vuoi ricevere la rivista bimestrale in formato cartaceo e nella versione completa

